Qualche giorno fa mi è arrivata dal Messico una telefonata capace di colpirmi come una fucilata dritta al cuore. All’apparecchio c’era il mio amico Beto Sanchez che mi dava la tristissima notizia della morte di Canek, suo figlio amatissimo. Canek, nemmeno 40 anni, aveva da tempo dei problemi cardiovascolari; ricoverato in ospedale, è stato poi colpito da un’infezione polmonare che se l’è portato via velocemente, e per sempre. Beto, il mio amico e compagno Beto, piangeva disperato; abbracciandoci idealmente a migliaia di chilometri di distanza, ci siamo salutati con un affetto struggente, e lui mi ha detto: “Adesso devo pensare al funerale e a tutto il resto. Ma ci sentiamo presto perché dobbiamo scrivere di mio figlio, e di quello che faceva: era un bravissimo scrittore, sai?, e non solo. Mi piacerebbe che ne parlassimo e che pubblicassimo insieme le sue storie”. Infatti, Canek era davvero “un bravissimo scrittore, e non solo”: sono andato a cercare sue notizie, e ne sono rimasto sorpreso. Ma in fondo, non più di tanto: Canek doveva essere per forza così visto che era il diretto discendente di una stirpe nobilissima e ribelle, quella dei Sanchez e dei Guevara. Quel ragazzone pieno di vita ci teneva presentarsi con il doppio cognome, e chi al posto suo non lo avrebbe fatto? Si chiamava Canek Sanchez Guevara, figlio di Beto Sanchez e di Hildita Guevara, figlia di Ernesto Guevara. Beto era il nipote del Che. Quindi non poteva che essere un grand’uomo anche lui, e “rebelde”, parecchio: ribelle fino in fondo, e intellettuale impegnato politicamente. Scriveremo senz’altro io e Beto, di Canek, ma adesso voglio raccontare velocemente un altro pezzo di questa storia, che un giorno dovrà certo occupare più spazio di un semplice pezzo come faccio adesso, ma intanto la riassumo qui, che mi sembra arrivato il momento. Per me, è una storia bellissima e struggente, incredibile ma anche triste. Di quelle che rendono orgogliosi di averla incrociata, che capitano nella vita senza che te le aspetti e che te la riempiono, la vita. In maniera talmente forte da far pensare che poi ce la porteremo appresso, per sempre. Come è, del resto.
Nel periodo fra 1976 i il 1979 (il giornale chiuse a giugno di quell’anno) lavoravo al Quotidiano dei Lavoratori, un giornale che dava voce ad uno vasto spezzone di militanti e simpatizzanti che si ponevano alla sinistra del Pci: chi ha vissuto come me quegli anni sa bene di cosa parlo. Giovane e idealista com’ero non mi consideravo un giornalista ma piuttosto impegnato in qualcosa di meraviglioso, che avrebbe cambiato – ne ero fortemente convinto – nel giro di poco la vita del nostro Paese, e non solo. Illuso, naturalmente, io come tanti altri, ma ci credevo e ci credevamo, eccome. Eravamo in tanti in quel posto, una vera fucina in ebollizione; io, ancora adesso, lo considero “magico” per la mia formazione, e tutti in un modo o nell’altro ci sentivamo immersi in quella sorta di costruzione dell’avvenire, anche sentendoci – come senz’altro eravamo – uguali l’un l’altro. Oltre a chi scriveva il giornale c’erano tante altre persone per i diversi servizi, tecnici soprattutto. Non solo italiani, ma il nostro universo comprendeva anche “compagni” provenienti da tanti altri Paesi, e non mancavano certo i latino-americani: rifugiati politici – naturalmente – con storie terribili alle spalle, che se non le raccontavano loro era meglio non chiedere. Mi ricordo per esempio di Hugo, montonero uruguaiano chissà come arrivato fin da noi. Dopo molte reticenze – e solo dopo essere assolutamente sicuro di potersi fidare – mi aveva raccontato ridendo di come fosse riuscito a sopravvivere per mesi alle torture guardando in faccia il soldato che gli metteva gli elettrodi ai genitali, e quando questi lo facevano sobbalzare di dolore, lui gli urlava: “Continua e non smettere, hijco de puta, tanto sono più forte di te!”, e guardare in faccia il suo torturatore che magari solo per un attimo restava imbambolato da tanto coraggio, era per lui una soddisfazione grandissima; “Poi – mi diceva – magari quel bastardo ci avrà pensato a quello che mi stava facendo, e forse si sarà sentitouna mierda. Il lavoro politico è anche questo, eh?”. Era magrissimo, Hugo, e sembrava che si spezzasse da un momento all’altro, ma se non ci riuscirono in Uruguay, figurarsi se poteva succedere qui. Aveva anche una moglie, Liliana Celiberti, anche lei in precedenza massacrata per anni dai militari e poi riparata in Italia. Un giorno sparì, e sapemmo che era rientrata illegalmente in Uruguay per riprendere la lotta con i suoi compagni; l’avevano presa quasi subito, Liliana, e poi è desaparecida, per sempre. Non so quante volte ho pensato di andare all’Ambasciata d’Uruguay a Roma per chiedere sue notizie (e di conseguenza anche di Hugo) adesso che quelli che erano montoneros sono andati al Governo con José Mujica, ma non l’ho mai fatto: troppa la paura di venire a sapere che anche il mio amico – esilissimo come un giunco malato – non c’è più da chissà quanto tempo, com’è probabile.
Ho scritto qui nome e cognome di Liliana perché poi è diventata un’eroina della lotta nel suo Paese ed è riconosciuta per esteso e per quello che era, ma gli altri nomi di quel nostro universo straniero non so se fossero veri, quello di Hugo compreso. Così come non sapevo se fossero reali quelli di una coppia di compagni messicani con i quali era scattata un’immediata simpatia. Sinceramente, non mi ricordo come decisero di chiamarsi allora, ma magari non sbaglio azzardando Maria e Miguel. Ricordo che avevano un figlio piccolissimo, e che non erano certo due compagni qualsiasi. Per esempio, partecipavano spesso alle riunioni di redazione (erano aperte a tutti) e quando intervenivano nelle discussioni – che erano naturalmente a contenuto politico, pur se si trattava di cronaca stretta – lo facevano sempre con grande cognizione di causa. Lei era dimafonista (un mestiere ormai morto da tempo: sbobinava le registrazioni dei corrispondenti esterni e le trasformava in “strisciate” che poi venivano passate per la correzione e l’impaginazione) e lui fattorino, se non sbaglio: faceva la spola tra la redazione a Milano e la tipografia a Rozzano.
Il giornale chiuse, e ci perdemmo quasi tutti di vista. Finché, un giorno dell’estate 1995 (me lo ricordo benissimo) ero in vacanza in Grecia e mi capitò fra le mani il settimanale del Corriere della Sera. Fra le altre cose, ampio spazio era dato a Hildita Guevara, figlia di Ernesto. Una lunga intervista nella quale – mi ricordo che il collega del Corriere scrisse proprio così – “all’ultima domanda mi risponde in italiano”, tanto che aggiunse poi, a mò di spiegazione: “Sì, sono stata in Italia per qualche anno, e ho lavorato alla redazione torinese del Quotidiano dei Lavoratori”. Una piccola bugia – quella della città – inserita in una grande verità, e guardando la fotografia in testa al servizio non ho avuto dubbi: era Maria (o un altro nome che non ricordo), che lavorava con me a Milano, e dire Torino doveva essere un piccolo e veniale tentativo di depistaggio automatico, se mai qualcuno avesse voluto indagare ancora, a tanti anni di distanza. Mi si bloccò il respiro: senza saperlo avevo lavorato con la figlia del Che! E non solo: anche pranzato con lei, riso e scherzato insieme, mi ero fatto dare del “destro” e a lei e suo marito avevo dato degli estremisti, in una situazione che già noi di Democrazia Proletaria lo eravamo qui considerati che di più quasi non si poteva. Mi ricordo che pensai come quegli anni mi avessero dato tanto fin troppo, in termini di fortuna e crescita, in ogni modo e senso. Poco tempo dopo venni a sapere che Hildita era morta per un tumore al cervello, ancora molto giovane, e per la seconda volta il nostro filo sembrò interrompersi senza però intaccare l’enorme sorpresa di aver scoperto l’aver vissuto per un lungo periodo le stesse emozioni della figlia di Ernesto Che Guevara. E le stesse anche di suo marito, che chissà la fine che aveva fatto, e che pensavo non avrei probabilmente recuperato mai più.
Ma a metà degli anni 90 nemmeno si sarebbe potuto immaginare il contorno di qualcosa di simile a Facebook. Di anni, da allora ne sono passati ancora tanti ma doveva essere scritto che quel nostro cordone non si dovesse spezzare mai del tutto. Infatti, un giorno di tre anni fa, a richiedermi l’amicizia su fb fu qualcuno dal Messico, che però dal nome e cognome non mi diceva niente. E’ stato un suo messaggio privato ad aprirmi il nostro mondo in comune, di nuovo: era Beto Sanchez, “il marito di Maria”. Quando in chat mi chiese se ero proprio io “quel” Tiziano Marelli, io gli risposi una cosa sola, precisa: “Se ho capito chi sei tu, invece, devi avere dei parenti con un cognome pesante”. Beto mi chiamò al telefono qualche giorno dopo, una domenica pomeriggio, e in due ore di colloquio serrato e accorato mi ha narrato di trenta e più anni di vita: in pratica, tutta la sua (e loro) storia. Lui e sua moglie erano arrivati in quegli anni direttamente da Cuba, con passaporti falsi e senza che nessuno conoscesse la loro identità, nemmeno l’ambasciata cubana nel nostro Paese: perfetti clandestini – ma con documenti apparentemente originali – poi praticamente lasciati al loro destino. Chiuso il nostro giornale si erano poi trasferiti a Roma, non smettendo nemmeno da lì di continuare nel loro impegno politico. Poi, l’innalzarsi dell’allarme Brigate Rosse e il livello d’attenzione verso le comunità straniere che potevano risultare collegate a quel gruppo terroristico (in verità, parecchio lontane dal loro agire politico) li costringe ad un giro europeo che può contare su una sorta di “internazionale” dell’appoggio a persone come loro, e del quale non ho chiesto naturalmente particolari. Dopo un lungo girovagare Beto, Hildita e Canek (che era diventato grandino, nel frattempo) approdano in Spagna, ormai apparentemente diventato un Paese a prova di fascismo. Anche qui sono attivi nell’impegno serrato stavolta nel sindacato, finché non accade il tentato golpe Tejero: nel giro di poche ore c’è da paventare un immediato ritorno alla clandestinità iniziando a far sparire tutto un archivio enorme di comunisti iscritti al sindacato prima che i militari ci mettano mano. Beto e Hildita si impegnano allo spasimo e ci riescono, anche se per fortuna il golpe fallisce. Passa ancora tempo, ed è per loro il momento di tornare in Messico, il Paese di Beto. Come è normale, il loro modus operandi non è mai cambiato, nemmeno in questa loro ultima tappa: sempre a fianco di chi ne ha più bisogno. E’ stato così con Hildita e anche dopo, quando lei se ne è andata per un male incurabile lasciando soli Beto e Canek. Che soli, in verità, sono sicuro non si sono mai sentiti.
Adesso, da qualche giorno Beto è davvero un po’ più solo, con un bagaglio personale ricco di ricordi pienissimi, maturati grazie ad una vita intensa e mai banale, nemmeno per un attimo. Tanti di quei ricordi sono ancora da raccontare, e magari per una parte lo faremo insieme. I fili che tengono uniti in questo modo le persone si rivelano più solidi dei cavi d’acciaio e vanno oltre ogni distanza, qualsiasi sofferenza e anche più di qualche momento (che resta indelebile) connotato da grande gioia di vivere. Come è stato per noi, che quei fili ce li siamo intrecciati un giorno ormai parecchio lontano, e da allora – grazie al destino e chissà che altro – è poi stato per sempre.
Grazie a Tiziano Marelli per l’articolo e la disponibilità. Potete seguirlo su www.tizianomarelli.com
Grazie a Tiziano Riverso per l’apprezzatissima nota artistica.
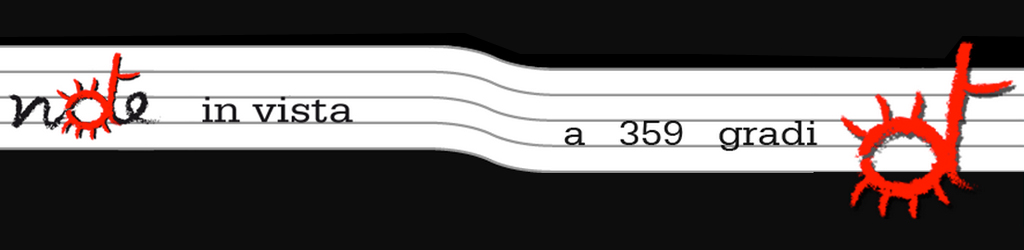









Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.